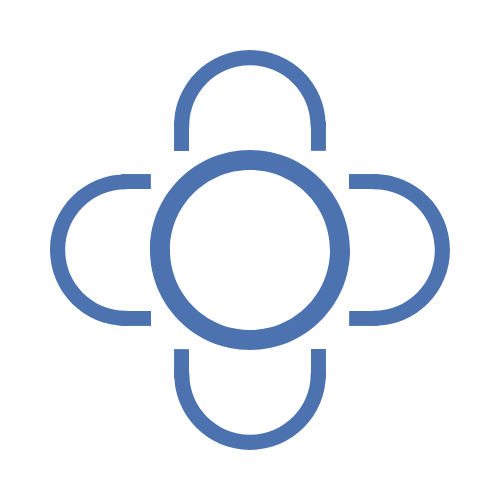La speranza non delude. E’ la certezza che Francesco, un papa che ha avuto la possibilità di celebrare due Giubilei (quello della misericordia nel 2016 e l’attuale), comunica ai fedeli e a tutti in vista della conclusione del primo quarto di secolo del terzo millennio.
Il Giubileo del 2025 si colloca in un tempo di inquietudine e preoccupazione per le tante situazioni di conflitto aperte nel mondo e per l’insufficiente impegno nel contrastare i processi di riscaldamento globale che mettono a rischio molte zone della terra. La tentazione della disperazione, e di conseguenza del ripiegamento su di sé, e della rassegnazione è forte.
Grande è il bisogno di ritrovare le ragioni della speranza, che muovano a passi concreti nella direzione della pace e della sostenibilità. Un anno intero nel segno della speranza, dunque, dopo che nel 2016 si è celebrata la misericordia divina e la necessità di praticarla.
Quello del 2025 è il venticinquesimo Giubileo ordinario della Chiesa Cattolica. Una tradizione che viene da lontano, che ha attraversato epoche diverse e si è confrontata con le tempeste della storia, ma pure con i dubbi e le trasformazioni della Chiesa.
Il Giubileo è – sin dal nome – un moltiplicatore delle gioie e delle speranze: il felice incontro tra la Chiesa e il bisogno degli uomini e delle donne di ogni generazione di sentirsi sostenuti nelle proprie attese, visioni, sogni. E dal bisogno di essere perdonati.
Cogliendo tale necessità, e reinterpretando l’accompagnamento che la Chiesa esercita a vantaggio dei più fragili e dei più deboli – ovvero di quasi tutti noi – papa Francesco ha scelto di porre l’Anno Santo sotto il segno della speranza.
“Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L’imprevedibilità del futuro […] fa sorgere sentimenti a volte contrapposti: dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Incontriamo spesso persone sfiduciate, che guardano all’avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro felicità. Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza”
(Spes non confundit)

La speranza è sfidata, in questo tempo. Il realismo, la rassegnazione, la sfiducia sembrano sensibilità ben più consone all’oggi piuttosto che uno sguardo speranzoso. Ma il Papa non cede al pessimismo: la notte finirà ed è possibile “rianimare la speranza”. Non siamo gente della rassegnazione o – peggio – della disperazione. I cristiani sono il popolo della fede e della speranza. E la speranza – l’apostolo Paolo ne è convinto – non delude.
Il pellegrinaggio alle origini del giubileo cristiano
Come nasce il giubileo nella Chiese d’occidente e quali sono le sue origini? La radice storico religiosa del giubileo è nel pellegrinaggio.
In questo senso il giubileo viene da molto lontano. Il pellegrinaggio, inteso come viaggio verso una remota terra sacra, si impone come una costante nel corso della storia. L’idea è legata, di volta in volta, alla frequentazione di luoghi santi, al culto delle reliquie, alla venerazione della Vergine e dei santi, alla pratica della penitenza, alla fede nei miracoli. Un fenomeno religioso che nel mondo cristiano si colloca nella sfera delle tradizioni cattolica e ortodossa. Esso rappresenta un tratto permanente della pietà greca e latina e costituisce una tradizione fortemente radicata nelle chiese d’oriente e d’occidente che l’hanno praticata in maniera ininterrotta fin dai primi secoli.
Il pellegrinaggio è pertanto un fenomeno religioso che investe profondamente anche la cultura ebraica e quella musulmana, nonché le religioni orientali induista e buddista, che conoscono, in maniere differenti, questa pratica devozionale. Al di là delle diversità, in tutte le religioni si riscontra un sorprendente fondamento comune: il pellegrino è viaggiatore, è “homo viator”. Un fedele consapevole di dover camminare sia sul piano fisico che spirituale, su una strada che non è quella di tutti i giorni, una strada di “rottura” in rapporto con ciò che vive nell’ordinario. La via del pellegrinaggio impone a chi lo compie distacco e sacrifici, ma allarga il suo sguardo aldilà degli orizzonti abituali. Il pellegrino è spinto ad uscire da sé e da ciò che gli è familiare. Egli intraprende un viaggio verso l’esterno, ma contemporaneamente vive un’esperienza interiore di crescita spirituale che implica un affinamento della consapevolezza, il superamento di prove, la penitenza per i peccati commessi, la ricerca di benefici spirituali, come le indulgenze.